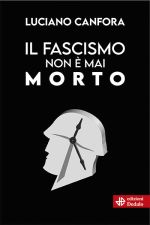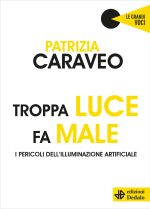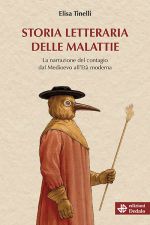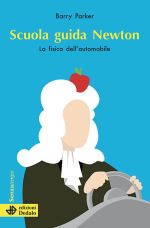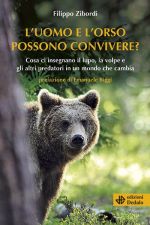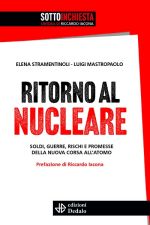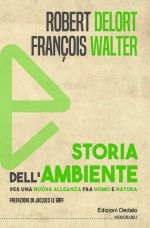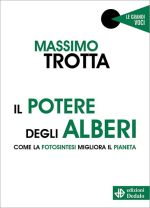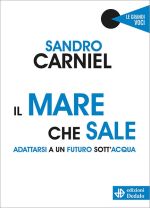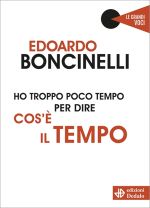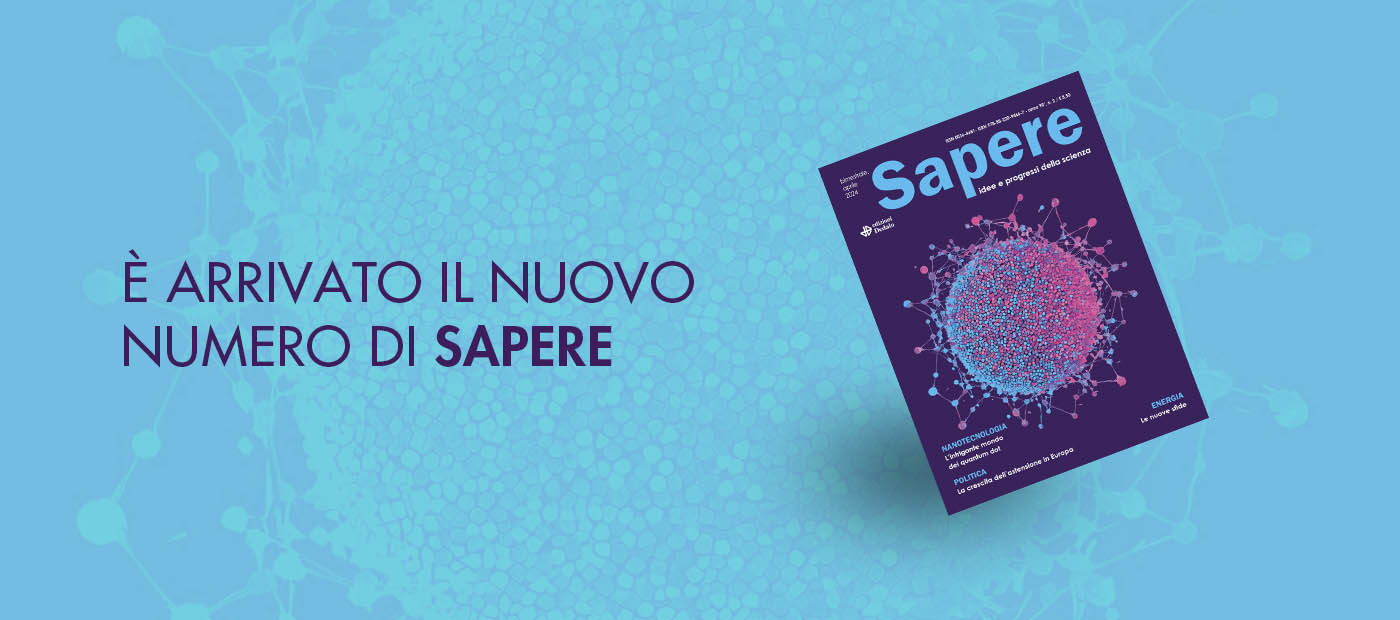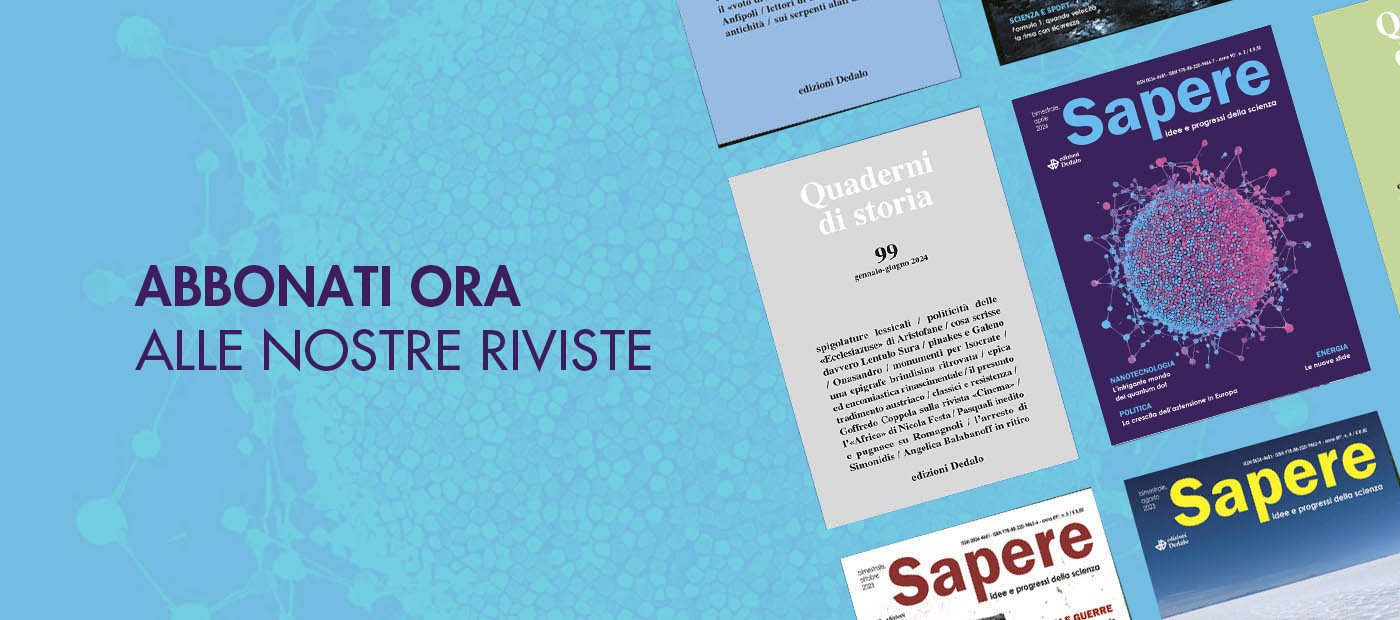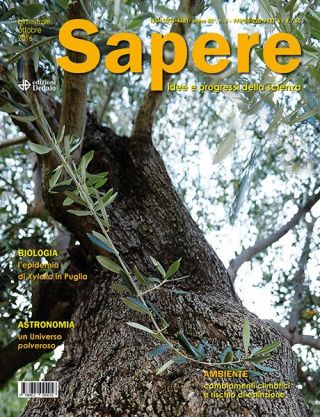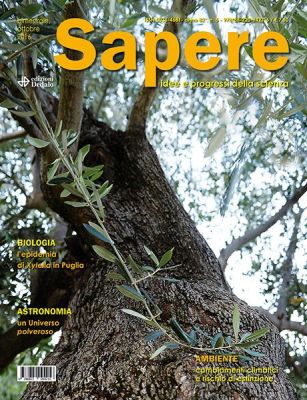Sapere 5/2016
L’epidemia di Xylella in Puglia
del Gruppo Linceo per la Xylella
Un Universo polveroso
di Maria Antonia Iatì e Cesare Cecchi-Pestellini
2020, l’anno che verrà
di Carlo Rondinini e Luca Santini
La massa: da Newton a Higgs
di Domenico Coiante
Influenza dei cambiamenti climatici sul rischio di estinzione
di Michela Pacifici
- ISBN: 9788822094216
- Fascicolo: Sapere - numero 5
- Anno: 2016
- Mese: settembre-ottobre
Direttore: Nicola Armaroli
Bimestrale
Bimestrale
Disponibile
Regular Price
11,00 €
- 5%
Special Price
10,45 €
Spedizione GRATUITA per ordini superiori a 29,00 €
Disponibile in 2/3 giorni lavorativi
 Articolo acquistabile con 18app e Carta del Docente
Articolo acquistabile con 18app e Carta del Docente
Transazione sicura
Gli articoli