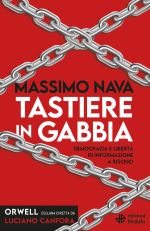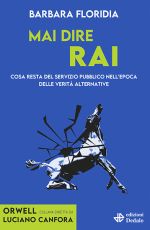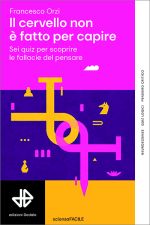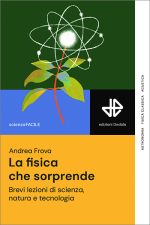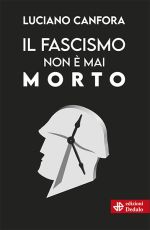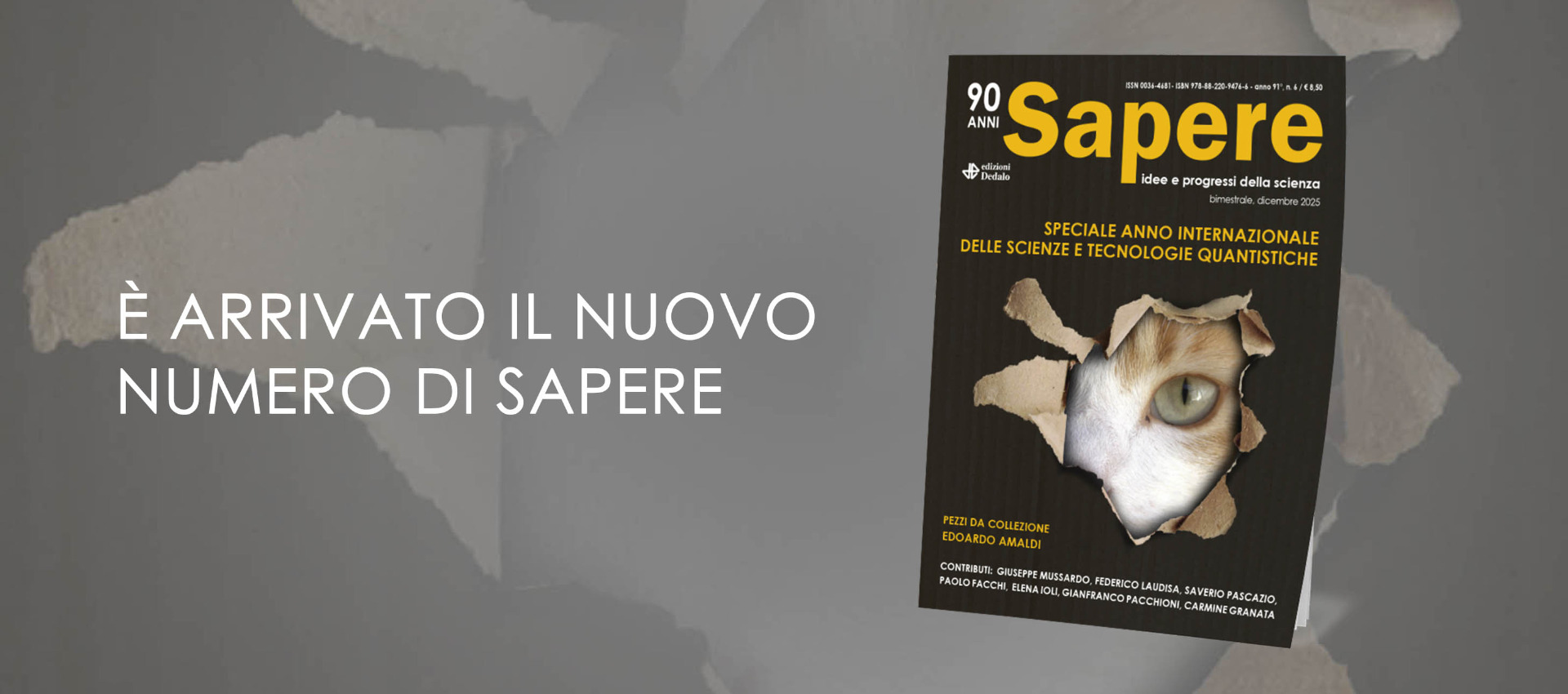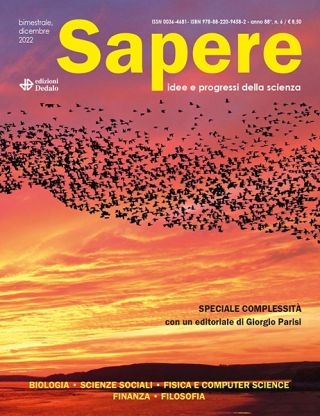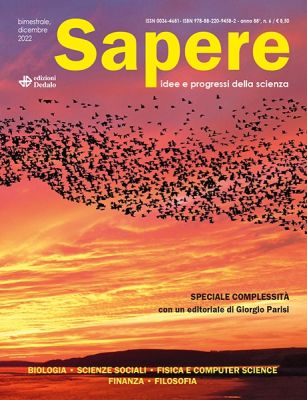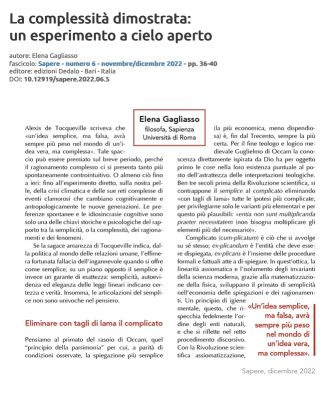Sapere 6/2022
Ecologia e sistemi biologici nel paradigma di Parisi
di Chiara Cammarota, Enzo Marinari
La complessità delle interazioni fra individui
di Andrea Baronchelli
La teoria della complessità nei problemi di ottimizzazione
di Maria Chiara Angelini e Federico Ricci-Tersenghi
La complessità in finanza: tra economia, matematica e psicologia
di Stefano Ciliberti
La complessità dimostrata: un esperimento a cielo aperto
di Elena Gagliasso
- ISBN: 9788822094582
- Fascicolo: Sapere - numero 6
- Anno: 2022
- Mese: novembre-dicembre
- Pagine: 64
Bimestrale
EDITORIALE
Impreparati alla complessità
di Nicola Armaroli
FILOSOFIA
La complessità dimostrata: un esperimento a cielo aperto
di Elena Gagliasso
ARTICOLI
I musei della matematica: complementi di materia!
di Sandra Lucente
SCIENZA A SCUOLA
BIOLOGIA
Ecologia e sistemi biologici nel paradigma di Parisi
di Chiara Cammarota, Enzo Marinari
FINANZA
La complessità in finanza: tra economia, matematica e psicologia
di Stefano Ciliberti
FISICA E COMPUTER SCIENCE
La teoria della complessità nei problemi di ottimizzazione
di Maria Chiara Angelini, Federico Ricci-Tersenghi
SCIENZE SOCIALI
La complessità delle interazioni fra individui
di Andrea Baronchelli
Quando abbiamo capito di non capire tutto?
di Vincenzo Palermo
STORIE DI SCIENZA
SOMMARIO
DAL MONDO
a cura di Luigi Minervini
GUEST EDITORIAL
Il tempo della complessità
di Giorgio Parisi
... Saverio Pascazio
di Giuliana Galati
A TU PER TU CON...
Una scultura dedicata ad Ada Lovelace
di Carla Petrocelli
SCATTI DI SCIENZA
LIBRI
IL RACCONTO
Viaggio di un professore tedesco
all’Eldorado
di Giuseppe Mussardo
LA MAPPA
L’estate senza fine
SCIENZA LIGHT
SCIENZA IN CUCINA
La complessità? È semplice
di Hervé This
HOMO MATHEMATICUS
Il battito fatale
di Roberto Natalini
CERVELLI NON IN FUGA
Uscire dalla moda usa e getta
di Riccardo De Marco
BIOTECNO-CHE?
Il presente biotech del latte
di Stefano Bertacchi
SPAZIO ALLA SCUOLA
Paolo Rossi e la complessità
di Stefano Sandrelli
SOMMARIO
RUBRICHE
FISICA TRA I BANCHI
Allenarsi a correre sulla sabbia
di Federico Benuzzi
LA FORMULA
Misurare la complessità
di Tommaso Castellani
INNOVAZIONE 4.0
Intelligenza artificiale e neuroscienze
di Paolo Berra
L’ISTINTO MUSICALE
La potenza “spettrale” della musica
di Philip Ball
 Articolo acquistabile con Carta cultura giovani e merito e Carta del Docente
Articolo acquistabile con Carta cultura giovani e merito e Carta del Docente